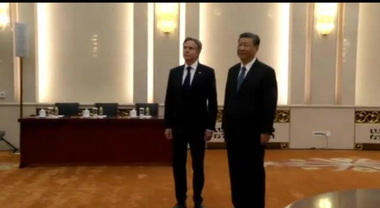Sta arrivando il Natale, ma la star dell’alpinismo italiano si è già fatta il regalo più bello. A metà dello scorso mese di maggio Nives Meroi, insieme al marito Romano Benet e a due amici, lo slovacco Peter Hamor e lo sloveno Bojan Jan, ha aperto una via straordinaria sul Kabru South, una gigantesca montagna di 7318 metri sul confine tra il Nepal e l’India. Nives Meroi, 62 anni, bergamasca trapiantata tra i boschi di Tarvisio, in Friuli, ha completato nel 2007 la collezione delle 14 vette himalayane che superano gli 8000 metri di quota. L’unica italiana, e la terza al mondo, ad aver compiuto l’impresa. È sempre stata una donna d’azione ma capace di pensieri profondi, come dimostrano le sue conferenze e i suoi libri, da “Il mistero del corvo timido” a “Non ti farò aspettare” dedicata alla malattia e alla guarigione del marito sul Kangchenjunga, la terza cima della Terra.
Tarvisio, d’inverno, è uno dei luoghi più freddi d’Italia. È vero anche quest’anno? Come vanno le cose lì da voi?
«Sono giornate strane, non c’è quasi neve, fa caldo. Non si può fare scialpinismo, le cascate di ghiaccio da scalare non si formano a causa del clima. Le piste da sci sono aperte grazie all’innevamento artificiale, chi viene in vacanza può sciare. Ma per noi che viviamo da queste parti è una sensazione strana, irreale».
Cosa resta, sette mesi dopo, della vostra grande impresa sul Kabru South?
«Restano le grandi emozioni, perché abbiamo vissuto un’esperienza bellissima su una montagna enorme, pazzesca e remota. Resta la gratitudine per Romano e per Peter, che hanno avuto un occhio creativo nel trovare la via giusta verso la cima. L’alpinismo non è solo forza, resistenza e tecnica, ma può essere anche un’arte».
Mentre voi eravate da soli sulla parete di ghiaccio del Kabru South, un migliaio tra alpinisti-clienti e guide sherpa faceva la fila per salire sugli 8848 metri dell’Everest. Cosa ne pensa?
«Sono contenta per il Nepal, sono soldi che arrivano in un paese poverissimo e che ne ha davvero bisogno. Ma questo non è alpinismo, è un turismo di massa che porta inquinamento ad altissima quota. C’è anche un inquinamento morale, c’è una ricerca ossessiva dei record».
Il momento più doloroso dell’anno è arrivato a fine luglio sul K2, quando un portatore pakistano è morto. Guide e clienti hanno continuato verso la cima, e al ritorno hanno scavalcato il suo cadavere.
«Che posso dire? È un alpinismo industriale, disumano».
Lei ha sempre detto che le donne possono praticare un alpinismo diverso da quello degli uomini. Nel 2023, però, nella ricerca dei record si è distinta la norvegese Kristin Harila, che ha raggiunto i 14 “ottomila” in 92 giorni. A settembre due alpiniste americane sono morte insieme ai loro sherpa sullo Shisha Pangma, in Tibet. Erano impegnate in una gara nonostante le condizioni pericolose, una valanga le ha uccise.
«È vero, sono addolorata per le vittime, dobbiamo fare di meglio. Resto convinta che competizioni e classifiche sono cose da uomini, e che noi donne dovremmo costruire un alpinismo diverso e più umano».
Nelle sue conferenze, che tiene insieme a suo marito Romano e sono seguite da centinaia di persone, riesce a parlare anche di questi temi?
«Noi raccontiamo le nostre esperienze, le nostre storie fatte di speranza, sofferenza e paura. Molte persone sono contente di ascoltarci, forse qualcuno preferirebbe un racconto più tradizionale e più eroico. Ma noi siamo fatti così».
Un anno fa, lei ha partecipato a un incontro sull’alpinismo e la montagna in Vaticano. Cosa le è rimasto dentro di quella giornata?
«Non sono religiosa, ma ho un ricordo molto bello. Ho ascoltato degli interventi importanti, ho conosciuto delle belle persone, ho detto qualcosa anch’io. C’è bisogno di un modo di andare in montagna più umano, e quella giornata è stata un contributo per cercarlo».
Gli anni passano anche per i grandi alpinisti. Come cambia, negli anni, l’adattamento dell’organismo all’alta quota per lei e per suo marito?
«Con gli anni la forza esplosiva diminuisce, ma la resistenza rimane. E si impara ad ascoltare il proprio corpo, che ci dice se continuare a salire o scendere».
In questi giorni, sulle Alpi e sull’Appennino, arrivano migliaia di persone che conoscono solo la montagna delle piste da sci, degli alberghi affollati e dello shopping. E’ possibile per loro, e soprattutto per le donne, scoprire anche una dimensione diversa?
«Il turismo alpino è diventato un’industria, un luna-park. In montagna è arrivata la logica della città, con piste di discesa affollate, luminarie e cene gourmet. Ma basta allontanarsi di poco dal traffico e dalla folla per scoprire il silenzio e la bellezza della montagna. Lo dovremmo fare anche noi montanari».
C’è qualche esperienza, qualche avventura alla portata di tutti che consiglia?
«Mia sorella fa la guida naturalistica, organizza delle camminate nel pomeriggio. Una delle più sorprendenti s’intitola “il lago che canta”. Si va a piedi o con le ciaspole sulla riva dei laghi di Fusine, ai piedi delle Alpi Giulie, e si ascoltano gli scricchiolii del ghiaccio. Si sente che la natura ha una voce, e che è importante ascoltarla».