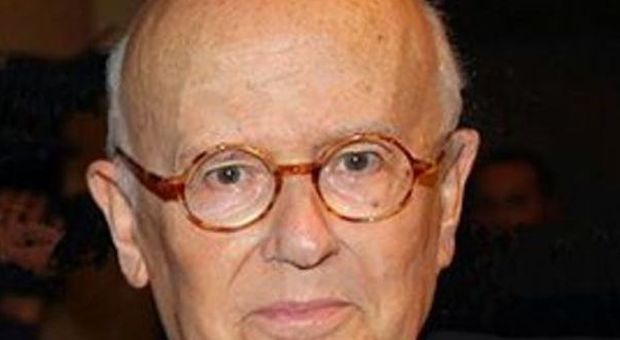Gervaso, una persona spiritosa come lei può essere davvero un depresso?
«Una persona spiritosa, soprattutto se ha un po’ di cultura, è doppiamente depresso. Subisce la depressione come insulto organico e la depressione come fatto morale. Uno pensa che l’ironia sia un antidoto alla depressione e invece è impotente in questo caso».
Perché lo humour non serve?
«Perché è il pudore della verità e la verità è tragica, quando sei depresso. E poi, quando sei depresso perdi tutto: anche lo humour. Perdi le virtù e i vizi».
Però Winston Churchill, depresso proverbiale, era una persona spiritosissima.
«Sì, ma non lo era nelle fasi di depressione. Se fosse stato depresso nel maggio del 1940, forse i tedeschi sarebbero riusciti ad invadere la Gran Bretagna. Un depresso non riesce a dire delle frasi tacitiane, come quella che Winnie pronunciò dopo che gli aviatori della Raf avevano respinto l’invasione nazista: ”Mai a così pochi così tanti devono tanto”. Pippo Civati una frase così non sarebbe capace di dirla».
L’ironia di Montanelli non era l’ironia di un depresso?
«Quando Indro era depresso, e io ho seguito tutta la sua sindrome, andavamo ogni mattina a Villa Borghese. Diceva: ”Io devo sfottere il mio fisico, camminando tre ore. Così perdo le forze e dormo la notte. L’indomani gli chiedevo: «Hai dormito?”. E lui: ”No, avevo paura di addormentarmi”. Per il depresso, il sonno è popolato di incubi, di serpenti a sonagli, di avvoltoi, di mostri a sei teste, di ippogrifi, di belve deformi».
Quanto ti appaiono questi orrori, tu che cosa fai?
«Se dormo, subisco. Ma il sonno è indotto dai sonniferi ed è condizionato dagli psicofarmaci. Io per fortuna da qualche anno sono fuori dalla depressione ma non riesco a dimenticarmela mai».
Come la definiresti in due parole?
«Ne uso tre: fossa dei serpenti. Oppure: rogo dell’anima. La cosa peggiore, per il depresso, è l’incomprensione della gente».
Chi ti conosce, sa che hai avuto quasi tutte le malattie. La depressione, nella classifica delle sofferenze, a che punto sta?
«È la numero uno in una graduatoria in cui c’è soltanto lei. È una malattia a sé. Ho avuto la fortuna di avere un tumore alla prostata, 15 anni fa, che mi ha reso impotente. Donandomi quella pace dei sensi, dopo una lunga milizia afrodisiaca che mi aveva stremato».
Sulle donne il fascino del depresso, e certo narcisismo della depressione quando c’è, funziona?
«Non lo so. Dobbiamo chiedere a mia moglie, Vittoria. Vitti, Vittiiii (ndr: Gervaso chiama la consorte che sta nella stanza affianco e le fa: ”Ti sembravo affascinante quando ero distrutto?”. Risposta: ”Mi sembravi terribile e mi facevi una gran pena. Il depresso può essere magari affascinante, soltanto visto da lontano e dal di fuori”)».
Gervaso, tu che conoscevi quel depressone di Vittorio Gassman non lo trovavi affascinante?
«Certo che lo era. Ma io l’ho visto nei momenti di depressione acuta e faceva tenerezza. Ti procurava mestizia vedere un uomo così vigoroso e macho, ridotto come un robot suonato, come uno zombie vagante».
Tu però, quando scrivi, sembri l’opposto di un robot suonato. Non è che giochi con la tua depressione?
«Puoi giocare con tutto. Io ho giocato anche con il tumore. Ma con la depressione non si scherza».
Scrivendo può passare?
«Passa soltanto con il tempo, con i farmaci e con una disciplina di vita spartana».
Quando ti è venuta e quando ti è passata?
«Avevo 18 anni. Ero in viaggio da Roma a Torino, nel 1956. Entrò una donna, francese, facoltosa e molto affascinante. Attaccai bottone con lei. Mi disse che si chiamava Babette. A un certo punto mi fece: ”Mio marito ed io, ogni anno, ci prendiamo un mese di eros sabbatico. Poi, al ritorno nella vita coniugale, ci raccontiamo tutto. O quasi”. Arrivammo a Torino e finimmo nella Locanda del camionista, dove facemmo pazzamente l’amore. Alla fine mi disse che voleva andare in un albergo più elegante, ma io non la potevo seguire: ero squattrinato. E allora lei: ”Io vorrei stare tutta la vita con te. Telefonami e se non lo farai mi toglierò la vita”».
Non l’hai chiamata e poi ti sei depresso?
«Quattro anni dopo, ero in America. Di colpo mi tornò in mente Babette e mi venne il chiodo fisso: si sarà buttata nella Senna. Caddi in depressione, mi diagnosticarono in una clinica psichiatrica una psico-nevrosi depressiva con spunti ossessivi».
E da allora?
«Nel 2008, vedendo una bara vuota nell’ufficio di un mio conoscente che faceva l’impresario funebre, chi mi sembra di trovarci dentro? L’immagine di Babette. Piombo in una depressione profonda, che durerà cinque anni».
Ci dica un aforisma sulla depressione e finiamola qui.
«È la morte più brutta perché ti mantiene vivo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA