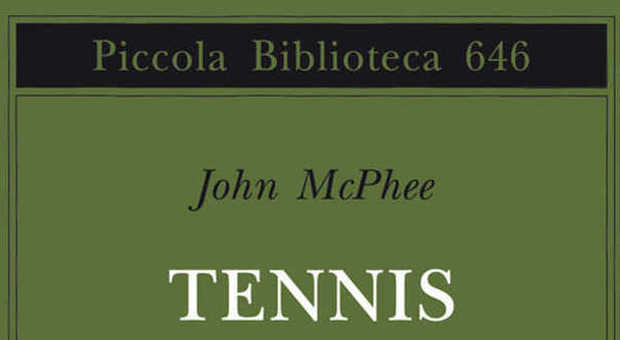In una disciplina di singoli come il tennis la storia è fatta di grandi dualismi: McEnroe-Borg, Federer-Nadal, oggi Djokovic-Murray, e quindi di sfide epiche disegnate da una volée quanto da un dettaglio laterale e all'apparenza significante. "Nel tennis i meccanismi motori traducono la storia personale e il carattere in colpi e caratteristiche di gioco" - scrive a mo' di tesi John McPhee in apertura del suo lungo articolo "Livelli di gioco", uscito in due puntate sul New Yorker oltre 40 anni fa e tradotto solo ora per la prima volta in italiano da Matteo Codignola per Adelphi nel volume "Tennis", insieme a una piccola gemma in appendice su Robert Twynam, leggendario giardiniere capo di Wimbledon.
Nel "più bel libro mai scritto sul tennis" (parola di Gianni Clerici) i protagonisti non appartengono all'Olimpo dei più grandi di sempre, ma sono due grandi giocatori "fotografati" al posto giusto nel momento giusto. Semifinale Us Open 1968 (non un anno qualunque), in campo a New York va di scena un derby a stelle e strisce tra due americani che più diversi non si può: da una parte della rete Arthur Ashe, nero, educato, democratico e sofisticato, simbolo del nuovo che - seppur a fatica - avanza. Dall'altra Clark Graebner, bianco, repubblicano e yankee fino al midollo, una specie di Mister America da Guerra Fredda, in grado di spazzare via con uno smash tutti i missili sovietici. John McPhee, futuro maestro del giornalismo non fiction, decide di raccontare l'irraccontabile, di rendere accattivante l'incubo di ogni lettore d'America (quello dell'hot dog e del rude football): raccontare una lunga e neanche particolarmente avvincente partita di tennis punto dopo punto e farla diventare uno spaccato della cultura e della società occidentale. Senza darlo troppo a vedere.
Così, in un puro stile New Yorker, fatto di lunghi paragrafi a sé stanti che poi, come tanti cerchi concentrici, arrivano al grande disegno finale, McPhee costella la manciata di ore che passano tra il primo servizio di Ashe e il match point decisivo di aneddoti, storie personali, personaggi più o meno accidentali, amori, politica e sogni chiusi negli armadietti: perché il tennis è - forse come soltanto il ciclismo - uno sport nobilissimo e bastardo, che chiede tutto e concede con la massima parsimonia, e i cui dei (ricordate Match point di Woody Allen?) assegnano trionfi e disfatte per un pizzichino del nastro, anche se è anche lo sport in cui finisce per vincere sempre il migliore. O almeno così speriamo per il futuro del nostro csmpioncino in erba Quinzi.
Dei dei e del destino, dicevamo. Ma dopo questa magistrale veduta aerea, se non olimpica, di una partita di tennis, McPhee decide di cambiare prospettiva e finisce a 30 centimetri da terra. Lì, da 44 anni, sta appostato il mago dell'erba di Wimbledon, Robert Twynam, che più che un giardiniere sembra un sacerdote (e infatti prega - lui solo - che a Londra piova spesso) e che valuta i giocatori in base alla loro clemenza con il terreno di gioco. Sotto questa visuale obliqua quanto serissima i migliori sono i "piedi fatati", quelli che possono danzare per ore sul manto verde senza lasciare una zolla fuori posto.
Così capita anche che sia Twynam ad azzeccare un pronostico impossibile, il campione in carica che perde sul Centrale al primo turno contro uno sconosciuto: "Era ovvio, non ha strappato un solo filo d'erba"...
© RIPRODUZIONE RISERVATA